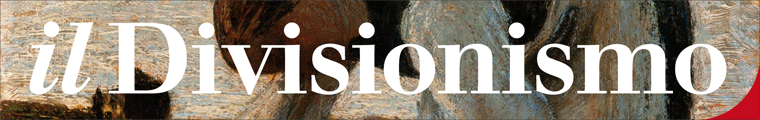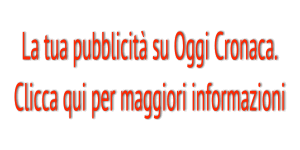Nella prima leggenda del Graal è detto che il Graal, pietra miracolosa che in virtù dell’ostia consacrata sazia ogni fame, apparterrà a chi per primo dirà al custode della pietra, il re quasi paralizzato dalla più dolorosa ferita: “Qual è il tuo tormento?”
(Simon Weil, L’attesa di Dio)
Oltre a Gerusalemme e a Costantinopoli in Italia ci sono alcune città che possiamo connettere con l’immaginario del santo Graal come emerge da una dozzina di romanzi medioevali a partire da Chretien de Troyes e fino al Perlesvaus: Venezia, in quanto custode di molte reliquie dalla quarta Crociata, Mantova, per le reliquie di San Longino in Sant’Andrea e la sacralità della stirpe dei Canossa, Asti per il ricordo della stirpe degli Atti, Monza per la corona ferrea e il ricordo di Teodolinda, Ravenna per il mosaico di San Vitale e quale “Costantinopoli d’Italia” e Pavia, altra città regale e sacrale per i Longobardi oltre che città militare profondamente romana come la biografia di San Martino rammenta.
Possiamo indicare in Italia anche dei possibili “borghi del Graal” oltre all’abruzzese Guardiagrele? Bobbio si rivela un candidato d’eccellenza, già a partire delle limitrofe pietre ofiolitiche chiamate: Pietra Perducca e Pietra Parcellaria, data l’associazione tra Graal e pietra nel Parziwal. Bobbio ancora oggi permettere di individuare molti elementi simbolici che possono rinviare all’immaginario graalico, a partire, ovviamente, dalle gesta del monaco pellegrino irlandese San Colombano che già nelle tappe del suo itinerario che lo portò fra i Longobardi sembra ricordarci luoghi arturiani-graalici.
Il santo monaco infatti partì dall’Irlanda e passando le sacre isole di Man e di San Patrizio giunse nella Cornovaglia di Artù e del suo castello di Tintagel e all’abbazia di Bodmin-Fowey Moor (zona dell’occultamento di Excalibur) per poi passare a Soissons e ad altre città della Neustria ed Austrasia fino a Basilea e Costanza. Fu San Colombano a fondare il cammino dei Franchi (la via francigena) quale via sacra e lo generò così: fondando monasteri dove passava con i suoi monaci compagni, come Sant’Omer e San Gallo, e gettando le basi spirituali della futura Lotaringia. Fu quindi ospite della santa regina bavara Teodolinda la cui cappella di Monza reca affrescati recipienti graalici e le cui vicende l’assimilano a Galla Placidia per saggezza, spiritualità e importanza politica per la cristianizzazione della confederazione longobarda.
Lo stesso segno della “Colomba”, così caro ai Longobardi, e che si posò miracolosamente sul santo monaco appare il più importante segno della presenza del Graal per il poeta cavaliere Wolfram von Hesembach. E così per il segno del sole radiante, emblema dell’Ordine monastico della Colomba, fra Pavia e Bobbio. A livello invece di immaginario di recipienti sacri anche qui gli indizi graalici si sprecano: il racconto della mistica “scodella di San Colombano”, il vaso di alabastro donatogli da Papa Gregorio quale reliquia di Cana di Galilea (ricordato nel suo sepolcro nell’abbazia omonima di Bobbio) e altri due recipienti pregevoli conservati nel Museo dell’Abbazia: la “teca eburnea” e il vaso di Orfeo rammentano l’importanza di questo immaginario simile a quello graalico.
Se poi l’emergere storico dello speciale rilievo di determinate narrazioni lascia spesso tracce nei nomi dei notabili di un territorio la mistica Bobbio, sede di uno dei monasteri e delle biblioteche più importanti della Cristianità medioevale, non ci delude neppure in questo aspetto: ben due dei suoi Vescovi recano il nome-epiteto di “Lancillotto”: Lancellotto Fontana, O.F.M. (5 ottobre 1409 – 1418) e Gaspare Lancellotto Birago (14 giugno 1746 – novembre 1765). Il nome di quest’ultimo è iscritto nel bordo del portale del Palazzo Vescovile bobiense, proprio davanti al trecentesco “Palazzo Alcarini”, già Balbi; palazzo chiamato popolarmente: “Casa di Teodolinda” a ricordo del pellegrinaggio del 622 che vide la regina dei Longobardi venire a Bobbio con il figlio a pregare sulla tomba del suo protetto.
Il tema della nominazione simbolica emerge in modo significativo anche nel nome del Prefetto di Classe che protesse la fuggitiva regina Rosamunda: Longino! Siamo poi proprio in un “tempo graalico” quello di Teodolonida e di Colombano, come emerge dai romanzi medioevali del Graal: tra Clovodeo e Carlo Magno si può infatti precisare il tempo narrativo del Graal come viene narrato nei romanzi due-trecenteschi franco-germanici. Se in diritto penale tre indizi fanno una prova qui ne abbiamo a decine. Aggiungiamo: la dicitura “terribilis locus est iste” (portale dell’abbazia colombiana e un’edicola del ponte romano), lo stemma con l’orso combattivo sul pavimento dell’abbazia (altare del transetto sinistro) a sua volta animale-segno associato a San Colombano, il monocromo dedicato all’Arca dell’Alleanza (transetto destro) e la crocefissione della navata sinistra nel Duomo.
Il dipinto è recente (autore: Luigi Morgari) ma l’iconografia appare inconsueta per il Novecento: un angelo raccoglie in un calice il sangue di Cristo fiottante dal costato. Un tema medioevale, già presente nella basilica francesca di Assisi ma abbandonato nei tempi moderni però qui a Bobbio ancora ricordato, secondo una “teologia del sangue” che appartiene alle profondità della spiritualità graalica. Possiamo quindi anticipare una prima provvisoria conclusione: San Colombano e la Bobbio dei Malaspina (da cui viene Papa Silvestro II) esprimono una spiritualità cavalleresca, imperiale e graalica che conferma narrativamente e simbolicamente la tesi dell’origine merovingia-longobarda della mistica saga.